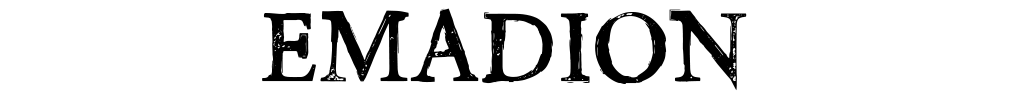I riti legati alla morte costituiscono, da millenni, uno degli aspetti più intriganti del vasto universo antropologico. Questi rituali non solo hanno lo scopo primario di onorare e ricordare i defunti, ma anche di esorcizzare la morte stessa. Dalle grandi civiltà alle più sperdute tribù, dalla più remota antichità ai giorni nostri: molteplici sono i rituali elaborati dagli uomini di ieri e di oggi.
Rituali, tuttavia, che sovente sfociano nel macabro, nell’invasamento, nel fanatismo, nel gore e – a seconda delle leggi in vigore – nell’illegalità più spinta.
Quello che andremo ad illustrare è, senza dubbio, uno dei rituali funebri più cruenti ed efferati. Destinazione India, alla scoperta della macabra pratica della Sati.
Da divinità a pratica terrena
In sanscrito è सती. Sati.
È da questa antica divinità induista che deriva il nome della omonima, macabra pratica funeraria. Per comprendere appieno le origini di questo rituale occorre, almeno in estrema sintesi, addentrarci all’interno del complesso e variegato mondo del pantheon induista e delle più radicate tradizioni filosofiche e religiose indiane ed orientali.
Sati è la personificazione della Prakṛti: un’astrazione di pensiero di difficile comprensione la quale, per semplificazione, può essere associata al nostro concetto di “Natura” o, meglio ancora, “forza motrice primordiale”, citando la “Bhagavadgītā”, divenuta un autentico testo sacro benché parte del poema epico “Mahābhārata”.
A volere che la “Natura” prendesse forma umana è Brahmā, il creatore dell’Universo.
Sati è figlia di Dakṣa – uno dei figli di Brahmā – e di Prasūti. Sati diventerà moglie di Siva, una delle divinità maschili più importanti dell’Induismo. Il matrimonio, tuttavia, è osteggiato – invano – da Dakṣa.
Il seguente episodio scaturirà l’origine della pratica del rituale. Dakṣa osa non invitare Sati e Siva ad un Yajña, un particolare rituale di sacrificio. Sati, tuttavia, decide di recarsi comunque al rito e di affrontare suo padre. L’episodio genera una lite tra Dakṣa e Sati, la quale – profondamente ferita dal comportamento del proprio padre – si immola, iniziando a bruciare dalle viscere del proprio corpo. Un’altra versione della storia afferma che Sati si getta tra le fiamme dei fuochi sacrificali impiegati durante lo Yajña.
Siva, in quel momento in meditazione sul monte Kailash, percepisce l’accaduto. Genera, allora, Virabhadra, un demone vendicativo il quale farà strage di tutti coloro i quali si sono opposti a Sati e Siva stesso. Anche Dakṣa non verrà risparmiato e verrà decapitato.
Sati, il sacrificio delle vedove

Il mito e i racconti legati a Sati non si esauriscono con il suo sacrificio ma, nel nostro caso, è sufficiente soffermarsi sul particolare madre di questo mito, ossia l’immolazione di Sati. Un episodio mitologico dal quale, tuttavia, nasce la pratica – assolutamente reale – della Sati.
Sembra che le prime tracce documentali di questa macabra pratica funeraria risalgano attorno al 510 a.C.; un indizio in tal senso ci viene da una stele eretta nella antica città di Eran, situata nell’attuale Madhya Pradesh, India.
In cosa consiste il rito funerario della Sati? Il rituale prevede che, morto il marito, la vedova si getti viva tra le fiamme della pira funebre allestita per il marito. Un’autentica immolazione, un suicidio rituale.
Esistono, in antichità, varie tipologie “ufficiose” del rituale. Nel nord dell’India, la donna viene legata ad un palo ed arsa viva mediante un braciere in bambù e legna colmo di sostanze grasse, così da rendere più efficiente la combustione.
Nel Bengala, sulle rive del Gange, si consuma un’altra forma del rituale: la donna, cosparsa di sostanze combustibili, è legata al corpo del proprio defunto marito e data alle fiamme in un braciere di paglia e palme. In altri luoghi dell’India, invece, il braciere è interrato.
Il suicidio rituale delle vedove è, evidentemente, un profondo, supremo atto di devozione coniugale verso il proprio consorte. Nei fatti si tratta di un suicidio ma, nei panni delle genti indiane, il termine “suicidio” appare improprio. Per le donne, anzi, la pratica funeraria della Sati è motivo di vanto e riscatto sociale: non tutte le donne possono ambire alla Sati e quelle che compiono la propria immolazione sono particolarmente meritevoli.
Tutte le caste sociali indiane abbracciano tale pratica ma, poiché i beni della vedova sono devoluti in eredità alla famiglia del marito defunto, la Sati si estende soprattutto tra le caste più benestanti e socialmente influenti, tra cui sacerdoti e militari.
Non tutta la multiforme India accetta questa pratica. Sikh, islamici della dinastia Moghul, molteplici induisti vietano o rifiutano tale pratica, da molti – già in passato – definita barbara e inutile.
L’occidentalizzazione dell’India – divenuta, nei secoli, colonia dei più importanti Paesi europei – conduce ad una graduale messa al bando della pratica della Sati.
È Lord William Bentinck, Governatore generale del Bengala dal 1828 al 1835 ad abolire per legge – nel 1829 – la pratica della Sati, operazione supportata anche dal Raja Ram Mohan Roy, personalità di spicco del riformismo indiano.
L’abolizione, tuttavia, non sortisce l’effetto sperato. In alcune zone dell’India (specie quelle a minor alfabetizzazione), la pratica resiste, anche sotto forma di coercizione nei confronti delle vedove, costrette con la forza ad immolarsi.
Le cronache redatte dalla Compagnia Britannica delle Indie Orientali offrono la misura del “fenomeno Sati”: dal 1813 al 1828, si calcolano in media circa 600 casi di immolazioni Sati all’anno. Si tratta, altresì, di cifre verosimilmente al ribasso: la pratica della Sati era, infatti, ben più estesa.
Il fenomeno, dal 1829, andrà gradualmente a scemare; in epoca contemporanea, si contano oltre 50-60 casi documentati a partire dal 1947-1950. Documentati, appunto: i casi di Sati non accertati, ignoti o interrotti potrebbero, anzi, sono molti di più.
Come negli anni successivi alla sua abolizione, la Sati è ancora oggi eseguita in zone particolarmente povere e sperdute. I casi certi, inoltre, aprono discussioni e dibattiti, anche al livello politico, circa la legittimità o meno di una pratica funeraria radicata nelle tradizioni e nel tessuto sociale più profondo dell’India. Documentati i controversi casi di Roop Kanwa (diciottenne immolatasi nel 1987), Charan Shah (55 anni, 1999), Vidyawati (35 anni, 2006), Janakrani (40 anni, 2006).
Sati: da divinità a macabro sacrificio. Fanatismo religioso, cieca esaltazione, viscerale, impenetrabile devozione: ingredienti di quella macabra suggestione chiamata Sati.
Questa pratica viene descritta anche nel libro “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne